Il gruppo di Elettronica Quantistica del Dipartimento
di Fisica dell'Università di Lecce ha iniziato nel 1998 la
realizzazione di un sistema LIDAR per il monitoraggio atmosferico.
Attualmente il sistema e' configurato per la misura delle caratteristiche
ottiche degli aerosol (retrodiffusione ed estinzione) e del rapporto di
mescolamento del vapore acqueo. Nel corso del triennio 2000-2002
abbiamo partecipato al progetto EARLINET, una rete europea di sistemi
LIDAR per lo studio degli aerosol. Esso rappresenta il primo
tentativo di realizzare una climatologia degli aerosol su scala continentale.
Per dettagli e per la consultazione della base di dati (uso limitato) si
può consultare il sito del progetto
Descrizione del sistema.
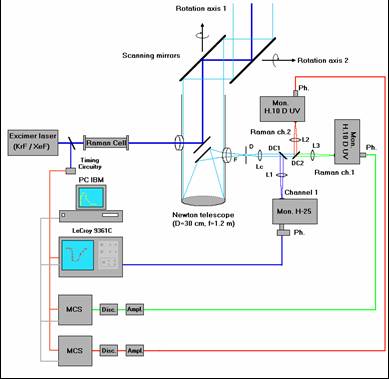 Artwork di Giovanni Torsello (1999)
Artwork di Giovanni Torsello (1999)
Il LIDAR si compone di un laser a eccimeri, un telescopio e un sistema
ottico, un sistema di rivelazione e acquisizione del segnale. Gli impulsi
hanno una durata temporale di circa 20 ns, con un'energia tipica di
100 mJ. La frequenza di ripetizione puo' arrivare a 100 Hz. La
configurazione della cavità laser è del tipo instabile, con
uno specchio concavo e uno specchio piano. Questa configurazione consente
di ridurre la divergenza del fascio.
Il fascio è inviato nell'asse di un telescopio di tipo newtoniano,
con uno specchio di 33 cm di diametro, e lunghezza focale 120 cm.
La luce diffusa è raccolta dal telescopio, collimata attraverso
una lente, e successivamente separata in diverse lunghezze d'onda.
Una prima separazione è ottenuta con uno specchio dicroico
operante a 45°, che fa passare la lunghezza d'onda di 402 nm, corrispondente
allo scattering raman del vapore acqueo, e riflette le lunghezze d'onda
minori. Questa parte di fascio e' successivamente divisa in due da un quarzo
in modo che circa l'8% della luce sia riflessa e il resto trasmessa.
Questi tre fasci sono analizzati spettralmente con tre monocromatori.
Sui fotomoltiplicatori all'uscita di questi monocromatori abbiamo
quindi 3 diversi segnali, corrispondenti alle lunghezze d'onda di 351, 382
e 402 nm, ovvero la lunghezza d'onda corrispondente alla diffusione elastica,
la diffusione Raman delle molecole d'Azoto e la diffusione Raman delle molecole
di vapore acqueo.
I segnali vengono registrati con la tecnica del conteggio dei fotoni.
Per il segnale elastico, che è molto più grande di quelli Raman,
si usa anche una rivelazione analogica/digitale per evitare problemi
di saturazione alle basse quote.
Questi segnali vengono mediati per il tempo desiderato e poi immagazzinati
nel computer che gestisce l'esperimento.
Le informazioni che si possono trarre da questi segnali sono:
a) dal segnale elastico da solo è possibile avere informazioni sull'altezza
del bondary layer e informazioni qualitative sulla distribuzione degli aerosol
b) dal segnale Raman dell'azoto è possibile conoscere il
coefficiente di estinzione totale e degli aerosol
c) dall'analisi simultanea del segnale elastico e del Raman dell'Azoto
è possibile ottenere informazioni quantitative sul coefficiente
di backscattering.
d) dall'analisi simultanea del segnale Raman dell'Azoto e del segnale
Raman del vapore acqueo e' possibile ottenere la misura del rapporto di mescolamento
del vapore acqueo.
I risultati iniziali di queste misure sistematiche stanno
per essere pubblicati in:
Applied Optics (2003) : preprint PDF
Journal of Geophysical Research 2003 : preprint
PDF
e sono stati presentati ad alcune conferenze, tra cui:
SPIE Remote Sensing, 23-27 Settembre 2002, Creta, Grecia (presentazione)
ILRC 2002,8-12 Luglio 2002, Quebec, Canada , ( poster
PDF)
Nel Marzo 2003 è stato acquisito un fotometro solare automatico. Questo strumento misura l'intensità della radiazione solare, diretta o diffusa, a diverse lunghezze d'onda. Queste informazioni possono essere utilizzate per calcolare alcune caratteristiche dell'atmosfera legate ai suoi componenti variabili, come il carico aerosolico e la quantità di vapore acqueo.
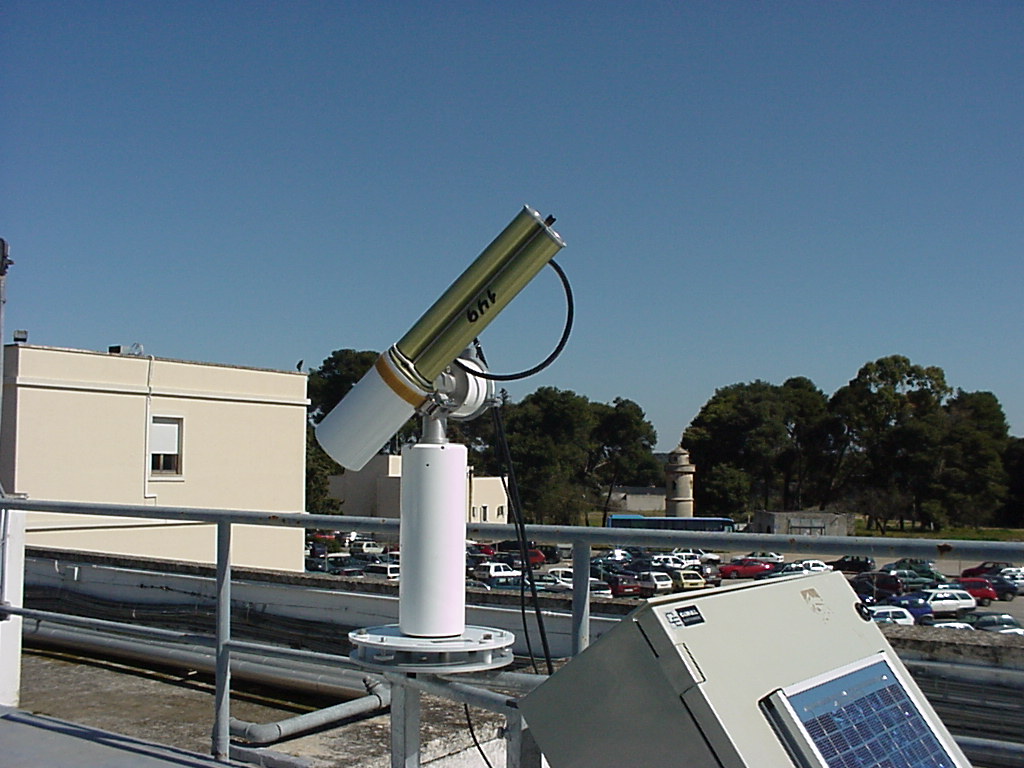
L'immagine mostra il fotometro solare (al centro della foto) montato
sulla terrazza del Dipartimento di Fisica. In primo piano il sistema di controllo.
Il fotometro può ruotare nel piano zenitale e azimutale in modo da
effettuare, a orari prestabiliti, misure dirette della radiazione solare,
da cui si può dedurre lo spessore ottico dell'atmosfera, e misure della
brillanza del cielo a diversi angoli. Tramite diversi filtri interferenziali
queste misure sono fatte a diverse lunghezze d'onda.
Questi dati vengono trasmessi con una antenna satellitare al Goddard Space Flight Center della NASA,
sede del progetto AERONET.
Questo progetto è una rete mondiale di fotometri di questo tipo per
lo studio degli aerosol su scala mondiale.